Brilla Sempre
My mother passed away on March 28, 2023, after eighteen years of illness. Her name was Serenella.
Her identity card listed her as a “cleaner.” She earned a living cleaning buildings—stairs, courtyards, parking lots—in Treviso, our hometown in Northeast Italy. She would clean tirelessly, then come to pick me up from school on her Ciao moped, the kind you had to pedal to start. She rotated a series of identical tank tops, a sort of uniform. I remember her, glowing with sweat and happiness.
In the months after her death, I photographed the places where she had worked, places she had also taken me to as a child. It felt like group therapy: the building managers were the therapists, the residents their patients. Each of them had a fond memory of her.
↓ In basso la versione originale, in ITALIANO ↓
![]()
Her identity card listed her as a “cleaner.” She earned a living cleaning buildings—stairs, courtyards, parking lots—in Treviso, our hometown in Northeast Italy. She would clean tirelessly, then come to pick me up from school on her Ciao moped, the kind you had to pedal to start. She rotated a series of identical tank tops, a sort of uniform. I remember her, glowing with sweat and happiness.
In the months after her death, I photographed the places where she had worked, places she had also taken me to as a child. It felt like group therapy: the building managers were the therapists, the residents their patients. Each of them had a fond memory of her.
↓ In basso la versione originale, in ITALIANO ↓

ORDER![]()
TALKS & SIGNINGS
MUFOCO - Museo Fotografia Contemporanea
bruno, Venezia
Micamera, Milano
Leporello, Roma
Spazio Labò, Bologna
PUBLICATIONS
Marie Claire Italia
Il Sole 24 Ore
RECOGNITIONS
Selected as one of the best books of 2025 by Internazionale
PORTFOLIO
In collaboration with Micamera
PODCAST
Read by Luca Bizzarri
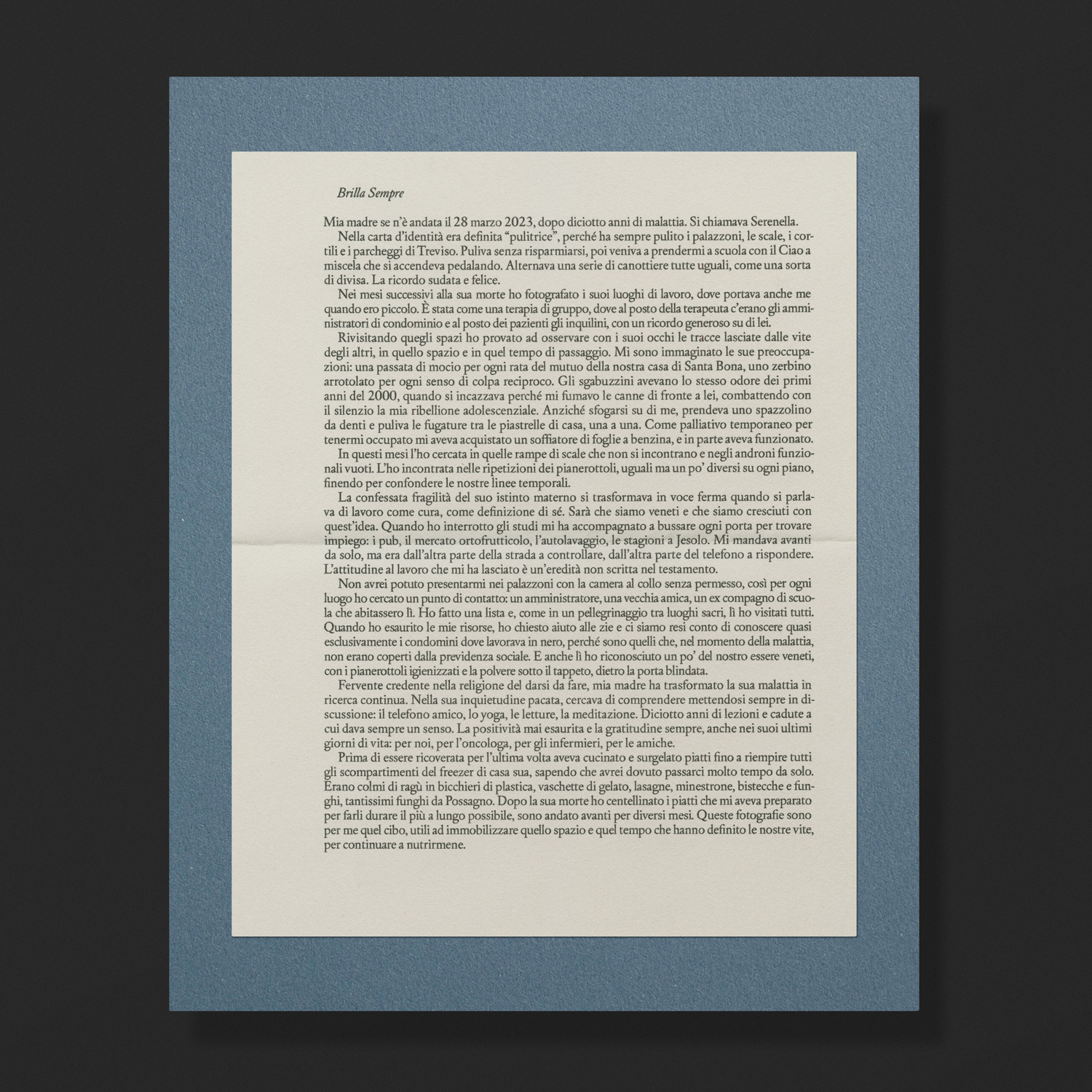
TALKS & SIGNINGS
MUFOCO - Museo Fotografia Contemporanea
bruno, Venezia
Micamera, Milano
Leporello, Roma
Spazio Labò, Bologna
PUBLICATIONS
Marie Claire Italia
Il Sole 24 Ore
RECOGNITIONS
Selected as one of the best books of 2025 by Internazionale
PORTFOLIO
In collaboration with Micamera
PODCAST
Read by Luca Bizzarri













Mia madre se n’è andata il 28 marzo 2023, dopo diciotto anni di malattia. Si chiamava Serenella.
Nella carta d’identità era definita “pulitrice”, perché ha sempre pulito i palazzoni, le scale, i cortili e i parcheggi di Treviso. Puliva senza risparmiarsi, poi veniva a prendermi a scuola con il Ciao a miscela che si accendeva pedalando. Alternava una serie di canottiere tutte uguali, come una sorta di divisa. La ricordo sudata e felice.
Nei mesi successivi alla sua morte ho fotografato i suoi luoghi di lavoro, dove portava anche me quando ero piccolo. È stata come una terapia di gruppo, dove al posto della terapeuta c’erano gli amministratori di condominio e al posto dei pazienti gli inquilini, con un ricordo generoso su di lei.
Rivisitando quegli spazi ho provato ad osservare con i suoi occhi le tracce lasciate dalle vite degli altri, in quello spazio e in quel tempo di passaggio. Mi sono immaginato le sue preoccupazioni: una passata di mocio per ogni rata del mutuo della nostra casa di Santa Bona, uno zerbino arrotolato per ogni senso di colpa reciproco. Gli sgabuzzini avevano lo stesso odore dei primi anni del 2000, quando si incazzava perché mi fumavo le canne di fronte a lei, combattendo con il silenzio la mia ribellione adolescenziale. Anziché sfogarsi su di me, prendeva uno spazzolino da denti e puliva le fugature tra le piastrelle di casa, una a una. Come palliativo temporaneo per tenermi occupato mi aveva acquistato un soffiatore di foglie a benzina, e in parte aveva funzionato.
In questi mesi l’ho cercata in quelle rampe di scale che non si incontrano e negli androni funzionali vuoti. L’ho incontrata nelle ripetizioni dei pianerottoli, uguali ma un po’ diversi su ogni piano, finendo per confondere le nostre linee temporali.
La confessata fragilità del suo istinto materno si trasformava in voce ferma quando si parlava di lavoro come cura, come definizione di sé. Sarà che siamo veneti e che siamo cresciuti con quest’idea.
Quando ho interrotto gli studi mi ha accompagnato a bussare ogni porta per trovare impiego: i pub, il mercato ortofrutticolo, l’autolavaggio, le stagioni a Jesolo. Mi mandava avanti da solo, ma era dall'altra parte della strada a controllare, dall'altra parte del telefono a rispondere. L’attitudine al lavoro che mi ha lasciato è un’eredità non scritta nel testamento.
Non avrei potuto presentarmi nei palazzoni con la camera al collo senza permesso, così per ogni luogo ho cercato un punto di contatto: un amministratore, una vecchia amica, un ex compagno di scuola che abitassero lì. Ho fatto una lista e, come in un pellegrinaggio tra luoghi sacri, lì ho visitati tutti. Quando ho esaurito le mie risorse, ho chiesto aiuto alle zie e ci siamo resi conto di conoscere quasi esclusivamente i condomini dove lavorava in nero, perché sono quelli che, nel momento della malattia, non erano coperti dalla previdenza sociale. E anche lì ho riconosciuto un po’ del nostro essere veneti, con i pianerottoli igienizzati e la polvere sotto il tappeto, dietro la porta blindata.
Fervente credente nella religione del darsi da fare, mia madre ha trasformato la sua malattia in ricerca continua. Nella sua inquietudine pacata, cercava di comprendere mettendosi sempre in discussione: il telefono amico, lo yoga, le letture, la meditazione. Diciotto anni di lezioni e cadute a cui dava sempre un senso. La positività mai esaurita e la gratitudine sempre, anche nei suoi ultimi giorni di vita: per noi, per l’oncologa, per gli infermieri, per le amiche.
Prima di essere ricoverata per l’ultima volta aveva cucinato e surgelato piatti fino a riempire tutti gli scompartimenti del freezer di casa sua, sapendo che avrei dovuto passarci molto tempo da solo. Erano colmi di ragù in bicchieri di plastica, vaschette di gelato, lasagne, minestrone, bistecche e funghi, tantissimi funghi da Possagno. Dopo la sua morte ho centellinato i piatti che mi aveva preparato per farli durare il più a lungo possibile, sono andato avanti per diversi mesi.
Queste fotografie sono per me quel cibo, utili ad immobilizzare quello spazio e quel tempo che hanno definito le nostre vite, per continuare a nutrirmene.
Nella carta d’identità era definita “pulitrice”, perché ha sempre pulito i palazzoni, le scale, i cortili e i parcheggi di Treviso. Puliva senza risparmiarsi, poi veniva a prendermi a scuola con il Ciao a miscela che si accendeva pedalando. Alternava una serie di canottiere tutte uguali, come una sorta di divisa. La ricordo sudata e felice.
Nei mesi successivi alla sua morte ho fotografato i suoi luoghi di lavoro, dove portava anche me quando ero piccolo. È stata come una terapia di gruppo, dove al posto della terapeuta c’erano gli amministratori di condominio e al posto dei pazienti gli inquilini, con un ricordo generoso su di lei.
Rivisitando quegli spazi ho provato ad osservare con i suoi occhi le tracce lasciate dalle vite degli altri, in quello spazio e in quel tempo di passaggio. Mi sono immaginato le sue preoccupazioni: una passata di mocio per ogni rata del mutuo della nostra casa di Santa Bona, uno zerbino arrotolato per ogni senso di colpa reciproco. Gli sgabuzzini avevano lo stesso odore dei primi anni del 2000, quando si incazzava perché mi fumavo le canne di fronte a lei, combattendo con il silenzio la mia ribellione adolescenziale. Anziché sfogarsi su di me, prendeva uno spazzolino da denti e puliva le fugature tra le piastrelle di casa, una a una. Come palliativo temporaneo per tenermi occupato mi aveva acquistato un soffiatore di foglie a benzina, e in parte aveva funzionato.
In questi mesi l’ho cercata in quelle rampe di scale che non si incontrano e negli androni funzionali vuoti. L’ho incontrata nelle ripetizioni dei pianerottoli, uguali ma un po’ diversi su ogni piano, finendo per confondere le nostre linee temporali.
La confessata fragilità del suo istinto materno si trasformava in voce ferma quando si parlava di lavoro come cura, come definizione di sé. Sarà che siamo veneti e che siamo cresciuti con quest’idea.
Quando ho interrotto gli studi mi ha accompagnato a bussare ogni porta per trovare impiego: i pub, il mercato ortofrutticolo, l’autolavaggio, le stagioni a Jesolo. Mi mandava avanti da solo, ma era dall'altra parte della strada a controllare, dall'altra parte del telefono a rispondere. L’attitudine al lavoro che mi ha lasciato è un’eredità non scritta nel testamento.
Non avrei potuto presentarmi nei palazzoni con la camera al collo senza permesso, così per ogni luogo ho cercato un punto di contatto: un amministratore, una vecchia amica, un ex compagno di scuola che abitassero lì. Ho fatto una lista e, come in un pellegrinaggio tra luoghi sacri, lì ho visitati tutti. Quando ho esaurito le mie risorse, ho chiesto aiuto alle zie e ci siamo resi conto di conoscere quasi esclusivamente i condomini dove lavorava in nero, perché sono quelli che, nel momento della malattia, non erano coperti dalla previdenza sociale. E anche lì ho riconosciuto un po’ del nostro essere veneti, con i pianerottoli igienizzati e la polvere sotto il tappeto, dietro la porta blindata.
Fervente credente nella religione del darsi da fare, mia madre ha trasformato la sua malattia in ricerca continua. Nella sua inquietudine pacata, cercava di comprendere mettendosi sempre in discussione: il telefono amico, lo yoga, le letture, la meditazione. Diciotto anni di lezioni e cadute a cui dava sempre un senso. La positività mai esaurita e la gratitudine sempre, anche nei suoi ultimi giorni di vita: per noi, per l’oncologa, per gli infermieri, per le amiche.
Prima di essere ricoverata per l’ultima volta aveva cucinato e surgelato piatti fino a riempire tutti gli scompartimenti del freezer di casa sua, sapendo che avrei dovuto passarci molto tempo da solo. Erano colmi di ragù in bicchieri di plastica, vaschette di gelato, lasagne, minestrone, bistecche e funghi, tantissimi funghi da Possagno. Dopo la sua morte ho centellinato i piatti che mi aveva preparato per farli durare il più a lungo possibile, sono andato avanti per diversi mesi.
Queste fotografie sono per me quel cibo, utili ad immobilizzare quello spazio e quel tempo che hanno definito le nostre vite, per continuare a nutrirmene.